
Ma è proprio vero che lo spirito scientifico si caratterizza come una promozione di esistenza?
16 Giugno 2009
Ogni epos è fatto di storia e mito; e la nozione di «preistoria» è un pregiudizio occidentale
17 Giugno 2009di Maria Lamendola
classe 5^ A L.S.P.P.
Anno scolastico 2008-2009
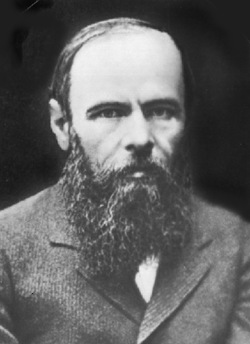
Fëdor Michajlovič Dostoevskij
Cenni biografici sull’autore
Fëdor Michajlovic Dostoevskij nasce a Mosca nel 1821 da un medico militare autoritario e violento. Il comportamento dispotico del padre avrà un’influenza negativa sulla psicologia del futuro scrittore che, mentre riserva un profondo affetto nei confronti della madre, prova per il padre un forte sentimento di odio. L’ultimo famoso romanzo di Dostoevskij affronterà proprio il tema di un dramma familiare, in cui è rappresentata la figura di un padre indegno, dai comportamenti riprovevoli: questo è stato visto come il riflesso della situazione di disagio che l’autore ha dovuto subire nella sua infanzia.
Per volere del padre, Dostoevskij presta servizio nell’esercito per due anni a Pietroburgo, ma il suo grande interesse per la letteratura lo porta a rinunciare definitivamente alla carriera militare e ad intraprendere esclusivamente quella di scrittore. Nel 1846 pubblica il suo primo, breve romanzo, “Povera gente”, e riceve l’ammirazione dei critici più famosi del tempo. Poco dopo esce il romanzo considerato un capolavoro del primo Dostoevskij, “Le notti bianche”, in cui coesistono una componente ancora romantica ( l’autore parla della bontà che si può rivelare in un uomo ), ma anche le premesse della sua futura indagine psicologica attenta e spietata, e della sua convinzione che l’uomo è capace di grandi malvagità. Gli ideali di impostazione romantica vengono infranti e abbandonati definitivamente dal 1849, anno in cui l’autore viene arrestato e condannato a morte per aver frequentato un circolo socialista. Poco prima dell’esecuzione però, lo scrittore apprende di essere stato graziato e che la pena è stata commutata in otto anni di lavori forzati in Siberia. Si tratta di anni durissimi, nei quali si manifesta nell’autore in forma acuta l’epilessia, il suo “male oscuro”, ed egli racconta questa condizione ne “I fratelli Karamazov”, attraverso l’epilettico Smerdiakov. L’esperienza della deportazione invece è descritta in un altro romanzo: “Memorie di una casa di morti”.
Tornato a Pietroburgo riprende l’attività di scrittore, ma si ritrova a dover affrontare gravi difficoltà economiche e la dura perdita della moglie e della figlia. Nel 1866 scrive “Il giocatore”, sotto le assillanti pressioni dell’editore, con il prezioso aiuto della sua stenografa, con la quale si sposerà l’anno successivo. “Il giocatore” tratta come tema centrale il vizio del gioco che lo scrittore conosce molto bene in quanto ne è caduto vittima egli stesso.
Nel 1867 è costretto a lasciare la Russia perché perseguitato dai creditori, e rimane all’estero per cinque anni, viaggiando in Germania, Francia, Svizzera e Italia. Durante questo periodo scrive un altro romanzo considerato uno dei suoi capolavori, “L’idiota”, al quale seguono poi “I Demoni” nel 1873, e “I fratelli Karamazov” nel 1879-1880.
Muore a Pietroburgo nel 1881, dopo aver guadagnato una grande fama in un vasto pubblico che lo ha apprezzato, e lo apprezza tutt’oggi, per la sua vertiginosa profondità di pensiero e di analisi.
Affinità tra la scrittura di Dostoevskij e psicologia, psicoanalisi e letteratura psicologica del primo ‘900
Dostoevskij, vissuto in Russia a fine ‘800, si è dimostrato uno scrittore decisamente all’avanguardia, i cui romanzi presentano tratti di estrema novità rispetto a quelli del suo tempo e di indiscutibile modernità, tanto da avere ispirato parte della narrativa dei primi decenni del secolo successivo. Inoltre può essere considerato, a livello letterario, il corrispettivo di quegli studi psicologici che proprio in quegli anni si cominciano a fare, se non addirittura un precursore inconsapevole sia della psicoanalisi che della letteratura psicologica del primo ‘900.
È infatti negli ultimi decenni dell’800 che, un po’ in tutta Europa, si costruiscono le basi per lo sviluppo della psicologia: la scienza che si occupa di studiare i fenomeni della psiche o dell’anima. Assieme ad essa nasce anche un’altra scienza, la sociologia, il cui compito è studiare il comportamento dell’individuo all’interno di un gruppo, ovvero come agiscono le persone all’interno dell’ambiente sociale. Sono gli anni del Positivismo: la rivoluzione industriale si diffonde, la borghesia si afferma come classe dominante nei Paesi più sviluppati ed emerge una grossa fiducia nelle scienze e nel progresso. Ė quindi con lo svilupparsi di medicina e filosofia positivista, che ritengono il metodo scientifico l’unico strumento adatto ad una corretta comprensione dell’uomo e della società, che psicologia e sociologia diventano due argomenti di grande interesse e ricerca.
Successivamente, nel 1900, anno della pubblicazione de “L’interpretazione dei sogni” di Freud, si assiste alla nascita di una nuova scienza: la psicoanalisi, scienza che si occupa di indagare nella mente degli uomini, nel loro “inconscio”, per poter comprendere determinati comportamenti e portare l’individuo a una migliore conoscenza e quindi al controllo e alla padronanza di sé. Prima la psicologia e poi Freud hanno senza dubbio il merito di aver dato il giusto rilievo a questi nuovi metodi di studio e di aver posto le basi del loro ulteriore sviluppo e della loro rapida diffusione, ma è sicuramente possibile individuare alcune delle loro importanti idee innovative, già in nei romanzi di Fëdor Dostoevskij, che sono contemporanei ai primi studi psicologici e precedono “L’interpretazione dei sogni” di qualche decennio. In tutti i suoi libri infatti ( da “Umiliati e offesi” del Dostoevskij ancora giovane, a “I fratelli Karamazov” del Dostoevskij già maturo) sono presenti profonde e dettagliate analisi psicologiche dei personaggi, descritti con lucidità e coerenza in ogni sfumatura della loro personalità. Lo scrittore ci propone dei nitidi ritratti di uomini qualunque, che ci vengono mostrati nei loro atteggiamenti più spontanei e con i loro pensieri più profondi. L’autore scava nell’interiorità dell’uomo per portarne alla luce la complessità e l’ambiguità. Egli giunge alla conclusione che in ogni uomo è presente sia il bene che il male e dall’interazione dei componenti di questo binomio, opposti ma al tempo stesso complementari, si delinea la personalità e l’agire dell’individuo. In termini freudiani si può dire che il comportamento del soggetto, dell’Io, è dato dall’equilibrio che si viene a creare tra Es ( pulsioni, desideri insiti nell’uomo ) e Super-Io ( la morale, le regole date dalla società ).
Fino a questo momento era prevalsa una concezione di uomo del tutto differente: non c’era l’idea di un individuo diviso da principi contrapposti, ma la convinzione che ogni soggetto fosse un’entità unitaria, in cui pensieri e comportamenti facessero capo ad un’unica personalità ben definita. Con Dostoevskij, e poi con Freud, emerge il volto sfigurato e sfaccettato di un uomo nuovo, che si trova ripetutamente in balìa di “voci” interne o esterne, e deve prendere la spesso dura decisione di quale, tra queste, ascoltare.
La grande differenza tra Freud e Dostoevskij sta però nel loro diverso modo di intendere l'”inconscio”, o il “sottosuolo”. Freud ritiene che l’uomo sia dominato dall'”inconscio”, ovvero da una dimensione oscura e sconosciuta che sta dentro di lui, e che nella maggior parte dei casi assume una determinata connotazione piuttosto che un’altra a causa dei traumi infantili che la persona in questione può aver avuto. Per Dostoevskij invece, il “sottosuolo” di ciascun individuo è teatro di un’eterna lotta tra bene e male ed ogni uomo, in ogni momento, è chiamato a scegliere liberamente se agire secondo il bene o secondo il male. Alla base della visione freudiana sta una concezione immanentista, mentre alla base di quella dostoevskiana sta una concezione trascendentale. Nel primo caso l’idea di fondo è che l’uomo non sceglie autonomamente come agire, ma le sue azioni sono determinate da un concatenarsi di eventi e situazioni che vengono dall’esterno e si ripercuotono sulla sua psiche; nel secondo, invece, l’uomo è completamente padrone delle proprie azioni, perché il Dio cristiano lo lascia libero di scegliere.
Dostoevskij, infatti, era un uomo costantemente proteso la fede cristiana, anche se – forse – non giunse mai a possederla interamente; ed è quindi chiaramente individuabile, nelle sue idee, una forte connotazione religiosa.
Ma veniamo ad altri elementi che inducono a parlare di una modernità di Dostoevskij rispetto alla letteratura europea a lui cntemporanea. Certamente gli si può attribuire il merito di aver affrontato per primo alcuni grandi temi che caratterizzeranno i primi decenni del Novecento e di aver introdotto e delineato il profilo di un particolare personaggio, l'”inetto”, che in questo periodo comincerà a definirsi sempre più. Dostoevskij, nelle sue opere, pone l’attenzione sulla psicologia dei personaggi, il suo intento è scavare nella loro mente per far emergere la loro più sincera e profonda interiorità.
Agli inizi del XX secolo, un numero non esiguo di scrittori si cimenterà in quest’operazione, ognuno mettendovi una personale rielaborazione, e questo avverrà all’interno di un raggio territoriale molto ampio: dagli inglesi Joyce e Woolf, agli italiani Svevo, Moravia e Tozzi, ai francesi Sartre e Proust, all’austriaco Musil, per non citarne che alcuni. Ma non solo. Ognuno di questi autori ha scritto almeno un romanzo in cui il protagonista è un “inetto”, ovvero un uomo incapace di affrontare la vita nel modo giusto, pieno di incertezze e timori, che non riesce ad integrarsi e a relazionarsi con gli altri. Pensiamo ad Emilio Brentani ( “Senilità”, Italo Svevo ), un uomo che non agisce, che si guarda vivere passivamente; ma pensiamo anche all'”Ulisse” di James Joyce e a sua moglie Molly, due personaggi immorali, caratterizzati esclusivamente da connotazioni negative, che indicano un forte disagio interiore e un’assoluta incapacità di trovare il giusto modo per affrontarlo; o ancora consideriamo “L’uomo senza qualità” di Musil: già nel titolo è definita la categoria di uomo a cui appartiene il protagonista. I tratti essenziali dell'”inetto” sono rintracciabili in molti dei personaggi che svolgono ruoli di primo piano nelle opere di Dostoevskij; un esempio lampante lo si ritrova in Fëdor Pàvlovič Karamazov, il padre degli eponimi fratelli, privo di sani principi, debole, per tutta la vita preda delle sue passioni; ma anche in Aleksej Ivànovič ( “Il giocatore” ), incapace di dare una svolta alla sua vita, imprigionato nella sua dipendenza.
Il perché di una massiccia diffusione di inettitudine in letteratura nel primo Novecento è da ricercare nella condizione sociale in cui si trovano gli intellettuali in questi anni, gli anni del Decadentismo. Con la crescita della classe sociale borghese, dell’industria, del capitalismo, gli intellettuali sentono di aver perso il loro ruolo di guida, di “vate”, sentono che all’interno della società non ricevono più il giusto riconoscimento, la giusta attenzione, e questo li mette in crisi. Sono due i modi in cui i Decadentisti si pongono davanti a questo problema: alcuni, come Rimbaud, Pascoli, D’Annunzio, si emarginano, si isolano, rifiutano il mondo con l’rrazionalismo, proponendo miti e rifugiandosi in essi ( maledettismo, estetismo, panismo, super-omismo… ); altri, come appunto Musil, Svevo, Moravia, ecc., osservano il mondo, entrano in esso con la loro razionalità per mostrarne i limiti, scavano dentro alla realtà servendosi della ragione per portare alla luce i limiti, l’inconsistenza delle certezze borghesi.
Perfino la tecnica letteraria del narratore interno che parla a ruota libera, seguendo lo scorrere dei suoi pensieri, è utilizzata sia da Dostoevskij che da parecchi degli scrittori sopra citati. Il protagonista di “Memorie dal sottosuolo” fa un lungo monologo, nella prima parte del quale si dilunga in ragionamenti contorti e capziosi; e così Molly Bloom, moglie dell'”Ulisse” di Joyce, nel diciottesimo capitolo del libro, si lascia andare ad un soliloquio completamente liberatorio. E ancora Zeno Cosini, nel famoso romanzo di Svevo, scrive per il suo psicanalista tutto ciò che ha provato, detto e pensato nei momenti più importanti della sua vita. Viene fatta questa scelta strutturale perché, facendo parlare direttamente il protagonista, il flusso continuo e libero dei pensieri risulta più spontaneo e, quindi, più realistico. È comunque facilmente intuibile che ci siano delle differenze tra monologo e monologo, a seconda del taglio che ogni autore sceglie di dare a quello del proprio romanzo. Sicuramente il monologo di Zeno Cosini che scrive per il suo psicanalista, a volte mentendo di proposito, altre inconsapevolmente, sarà diverso da quello di Molly Bloom, che da sola, di notte, invece di pensare al marito lontano pensa ai suoi amanti.
Fatte queste premesse generali in modo da creare le basi per la comprensione dell’argomento trattato in questa tesina nel suo insieme, verranno proposte qui di seguito tre recensioni, le quali, occupandosi ciascuna di analizzare la dimensione psicologica in uno specifico romanzo di Dostoevskij, saranno finalizzate a dare un esempio concreto e tangibile di quanto è stato detto finora.
Memorie dal sottosuolo (prima pubblicazione: 1864)
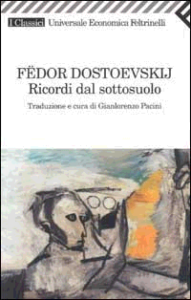
Copertina di “Memorie dal sottosuolo” di Dostoevskij
«Se le esigenze dell’Es sono eccessive, o se il Super-Io è troppo debole, o invece troppo rigoroso; può accadere che le istanze dell’Es divenute inconsce si manifestino allora con sintomi nevrotici…» ( C. Musatti ).
“Memorie dal sottosuolo”: già attraverso il titolo il lettore ha un primo ma pregnante avvertimento su quello che è il tema centrale che Fëdor Dostoevskij vuole trattare in questo suo famoso romanzo. Proprio così, perché pagina dopo pagina il lettore arriverà a rendersi conto di quale sia il significato allegorico della parola “sottosuolo” che ricorre spesso anche all’interno dell’opera. “Sottosuolo” sta per mente o psiche o inconscio, termine che adotterà qualche anno dopo ( inizio ‘900 ) il padre della psicoanalisi Freud. Tutto il romanzo è infatti un continuo scavo, una continua ricerca all’interno della contorta mente del protagonista: un uomo giovane, impiegato d’ufficio, che narra la sua storia in prima persona. Si tratta quindi di un lungo monologo, nel corso del quale il protagonista si svela completamente, porta alla luce tutto ciò che è depositato nel suo “sottosuolo”, ovvero nel suo inconscio.
È possibile dividere il monologo in due parti distinte: la prima è caratterizzata dall’esposizione contraddittoria da parte del protagonista-narratore delle sue idee in merito a se stesso a alla propria irrazionalità di fondo e appare come un ininterrotto flusso di pensieri, uno scavo profondo nella propria interiorità; nella seconda parte, invece, l’uomo che vive nel “sottosuolo” racconta alcuni eventi che hanno avuto un certo peso nella sua vita.
Quest’uomo è, usando un vocabolo adoperato molto da Freud, un nevrotico; in altri termini, è una persona afflitta da tormenti interiori, da veri e propri disturbi psicologici, un uomo affetto da uno squilibrio della personalità che deriva da un conflitto fra l’Io e il suo Es. Anche questo è rivelato al lettore con trasparente chiarezza già dall’inizio: il romanzo si apre, infatti, proprio con queste parole: “Sono un malato… Sono un malvagio. […] Non so un corno della mia malattia e non so con precisione dove ho male”.
Nelle duecento pagine del libro il narratore-protagonista si svela completamente, descrive in ogni minimo particolare gli stati d’animo, i pensieri più profondi, i desideri, le paure, che hanno dominato quei momenti della sua vita considerati da lui tra i più importanti.
Una sera egli ha preso parte, autoinvitandosi e dimostrandosi anche odioso e attaccabrighe, ad una cena organizzata dai suoi vecchi compagni di scuola; dopo di che li ha seguiti in una casa di tolleranza. Dopo essersi ripreso dalla forte ubriacatura, fa il moralista con la ragazza con cui ha trascorso la notte, parlandole della felicità che si può trovare nel condurre una vita pura e onesta; infine le lascia il suo indirizzo.
Dopo qualche giorno, la ragazza si presenta a casa sua, ma, al contrario di ciò che si sarebbe aspettata, viene accolta con rabbia e disprezzo. Lei, però, non si lascia impressionare, né demoralizzare e decide di restare a fargli compagnia, comprendendo che davanti a lei c’è una persona che soffre e che ha bisogno di aiuto. Subita, però, una pesante umiliazione, la giovane capisce di essersi sbagliata sul conto di quell’uomo e se ne va, senza farsi mai più vedere. Il protagonista vorrebbe richiamarla indietro; ma è troppo tardi, e il rimorso per il proprio comportamento lo accompagnerà per molti anni ancora.
In tutte le situazioni descritte nel romanzo, il protagonista ha avuto comportamenti strani, ha fatto discorsi quasi incomprensibili, ha agito in modo da provocare stupore, spesso anche rabbia nelle persone con le quali aveva a che fare; ma il lettore, leggendo anche i pensieri che ha avuto, la psicologia che stava dietro le sue azioni, è in grado di ricevere delle risposte, di soddisfare degli interrogativi. Il lettore si trova nella posizione privilegiata di colui che non vede le scene soltanto dall’esterno, ma anche e soprattutto dall’interno, dall’ottica duplice del protagonista. Trattandosi di un uomo in preda ad una malattia psichica, i suoi ragionamenti sono quasi sempre contorti, cavillosi, a volte slegati, spesso contraddittori; ma, alla fine, proprio per questo riescono a dare un’immagine esaustiva dei tormenti interiori, dei conflitti, delle angosce invincibili che affliggono questo personaggio. Inoltre, il fatto che egli abbia deciso di mettere per iscritto cose talmente personali e intime che lo riguardano ( tra l’altro, come egli stesso dice, non destinate ad un lettore, ma unicamente a se stesso ) potrebbe significare la sua volontà di liberarsi di certi pesi opprimenti, il tentativo di mettere un po’ d’ordine nel suo squilibrio mentale.
Capita spesso, però, che proprio lui stia quasi per perdersi nei labirinti della propria psiche, e a quel punto, capendo di essersi spinto troppo oltre, chiude bruscamente il lunghissimo ed evasivo discorso che aveva iniziato. Un chiaro esempio di questa dinamica è proprio in una delle ultime frasi del romanzo, quella che chiude l’ennesimo, delirante ragionamento del protagonista: “Ma basta: non voglio più scrivere «dal sottosuolo»…”.
Usando l’efficace tecnica letteraria del narratore interno, Dostoevskij accompagna il lettore in un viaggio nell’inconscio, lo guida in un percorso all’interno della mente di un nevrotico: ma fa tutto questo come in punta di piedi, come sottovoce. Leggendo, infatti, non si ha per niente l’impressione di seguire i pensieri di questo personaggio da quello che potrebbe essere il punto di vista di uno psicologo, o addirittura di uno psichiatra; non si ha, quindi, la sensazione di dover “analizzare il caso”, di studiare in chiave analitica la situazione; ma si ha semplicemente la consapevolezza di essere partecipi del tentativo di rivelarsi che compie quest’uomo.
È possibile, a questo punto, affermare che Dostoevskij può essere visto come il precursore della teoria dell’inconscio, teoria che sta alla base di quella scienza che nel 1900 nascerà con il nome di psicoanalisi e vedrà come fondatore Sigmund Freud.
Detto questo, si può riconoscere in Dostoevskij anche il precursore di tutta quella letteratura che, ispirandosi alla psicoanalisi, si affermerà nei primi decenni del ‘900 un po’ in tutta Europa. Sono infatti molti gli scrittori che in questo periodo rivolgono la loro attenzione ai labirinti oscuri della mente umana: da Svevo e Pirandello in Italia, a Woolf e Joyce in Gran Bretagna, a Kafka e Musil in Austria, a Proust in Francia, a Thomas Mann in Germania. Questi ed altri svariati autori, seppure ognuno con i propri caratteri distintivi, possono essere situati all’interno di un unico grande filone culturale, che rappresenta un’importante novità nella storia della letteratura. I loro romanzi puntano sempre più ad un’accurata analisi nei meccanismi della mente umana, per comprenderne e svelarne la complessità.
Ma non solo. Molti di questi romanzo vedono come protagonista un “inetto” o, in altre parole, un nevrotico; perciò, anche di questo Dostoevskij può essere considerato un anticipatore. L'”inetto”, ovvero l’uomo frustrato, solo, aggressivo, in conflitto col mondo, malato e diverso, incapace di fare alcunché di buono, è una figura ricorrente nella scrittura del primo ‘900. ( Zeno, Törless, Mattia Pascal ). Dunque, il nevrotico che comparirà ripetutamente nella produzione letteraria di inizio XX secolo, e che ha come caratteristica distintiva il fatto di essere un “vinto”, sconfitto non dalla vita ma da sé stesso, dalla mancanza di autentica volontà, affonda le sue radici già alla fine del secolo precedente, nelle opere di Dostoevskij. Il protagonista di “Memorie dal sottosuolo”, infatti, ha le tipiche caratteristiche dell'”inetto”: è un uomo problematico, che conduce una vita monotona e schiva e si perde continuamente in interminabili ragionamenti cavillosi e infondatamente paranoici.
Anche la tecnica narrativa del monologo, scritto o parlato o soltanto pensato, precorre tutta una serie di tentativi; lo si può trovare ne “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust, ma anche in “Gita al faro” di Virginia Woolf o in “La coscienza di Zeno” di Svevo. Si tratta di una tecnica molto efficace, che permette all’autore di dar voce direttamente ai suoi personaggi, avvicinandoli maggiormente al lettore e dandogli così un profilo più spontaneo e verosimile. Il monologo in questione confina nel soliloquio ed è il modo attraverso il quale il lettore può osservare il funzionamento di una persona, l’apparire di motivazioni diverse e contrapposte, di spiegazioni che non spiegano, di pulsioni che rinviano a strati profondi che sfuggono allo stesso protagonista. Insomma è una specie di vetrina non sono di quel che il protagonista pensa ma anche di quello che non sa di pensare.
L’affinità con Svevo è oltremodo evidente, perché il protagonista di “Memorie dal sottosuolo”, proprio come Zeno Cosini, non fa che contraddirsi; svelare qualcosa di sé, salvo smentirla subito dopo; dire mezze verità intuibili da parte del lettore… In entrambi i casi è un continuo parlare di sé, che l’io narrante dimostra di saper fare quasi con astuzia in determinate situazioni, nelle quali i fatti vengono presentati secondo il punto di vista che meglio riesce a farlo apparire sotto una luce favorevole; ma, con grande ingenuità in altre circostanze nelle quali ciò che risulta palese agli occhi del lettore sembra offuscato e reso poco comprensibile a quelli del narratore ( e ciò avviene perché in quei momenti è il “sottosuolo” che cerca di farsi spazio nella coscienza dei personaggi ).
Al di là di queste originali strutture narrative e innovative tecniche letterarie, Dostoevskij, per rendere più coinvolgenti e attraenti le trame dei suoi romanzi, si richiama molto al genere “romanzesco” tipico dell’800. Le sue opere sono arricchite da colpi di scena, intrighi complicati e misteriosi, forti passioni, omicidi, rivelazioni inaspettate; e i personaggi sono sempre figure singolari, insolite (ladri, prostitute, ubriaconi…). Tutto questo è il materiale che sta alla base di una profonda analisi di pensiero e che contribuisce a dare a questo scrittore uno stile narrativo decisamente personale, che ha sempre trovato un grande riscontro nel pubblico di ogni tempo.
I fratelli Karamazov (prima pubblicazione: 1879-1880)

Copertina de “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij
Una famiglia qualunque in una piccola città della provincia russa, una storia di inimicizia violenta tra padre e figli… Nella mente dell’autore questa doveva essere la prima parte di una vasta biografia dedicata al minore dei tre fratelli, Alëša, ma la “Storia di un grande peccatore” della quale si sono conservati alcuni piani e appunti rimase incompiuta.
Dmitrij, Ivàn e Aleksèj ( Alëša ) Fëdorovič Karamaziv: sono loro i tre fratelli protagonisti indiscussi del romanzo, sono le loro vicende a gettare le basi di questo lavoro, opera di un Dostoevskij già maturo. Tutto ha inizio dal rapporto che ogni fratello ha con il padre, Fëdor Pàvlovič Karamazov, il quale è descritto come un uomo privo di qualsiasi morale e i cui unici interessi nella vita sono rappresentati da alcool, donne, feste e divertimenti di ogni genere.
Dmitrij prova, nei confronti del padre, un sentimento di disprezzo, di odio profondo, che non è in grado di nascondere e che anzi degenera molto spesso in liti furibonde, talvolta anche violente. Questo rapporto diventerà, se mai possibile, ancora più teso quando entrambi finiscono per innamorarsi della stessa donna, Grušenka, la quale, rendendosi perfettamente conto della situazione, giocherà con il fuoco, tirando la corda ora con l’uno ora con l’altro, fino ai limiti della sopportazione. Dmitrij, come del resto tutti i personaggi principali dei romanzi di Dostoevskij, viene descritto con sottile precisione: la sua personalità emerge in modo chiaro, sia attraverso gli analitici brani descrittivi della voce narrante, sia attraverso i suoi comportamenti. Egli è abilmente raffigurato come un uomo impulsivo, che si lascia guidare dall’istinto e che ragiona sulle cose quando ormai è troppo tardi. Ha uno spirito prorompente, che lo induce a far uscire i suoi sentimenti in modo diretto e quindi amplificandoli, senza pensare minimamente a quali potrebbero essere le conseguenze. A volte, allora, queste violente esplosioni fanno emergere un Dmitrij iroso, testardo e attaccabrighe; altre volte, invece, ci viene rivelato un uomo pieno di voglia di vivere, divertente e fiducioso nei confronti della vita. È evidente qui la presenza dell’importante idea dostoevskiana del contraddittorio coesistere di bene e male in ogni uomo.
Ma passiamo, ora, ad Ivàn. Anche lui ha un rapporto decisamente conflittuale con il padre, ma sicuramente in maniera diversa dal fratello. Egli prova una forte avversione e una forte ostilità nei confronti di Fëdor Pavlovič, ma non la mostra mai apertamente, non la fa mai apparire in modo lampante. Tutto si riduce a ciò che può trapelare dai suoi atteggiamenti, dalle sue parole e dall’aiuto ovviamente indispensabile della voce narrante. Il suo profilo psicologico è assolutamente coerente. Ivàn, infatti, appare nel libro come un personaggio ambiguo: molto introverso e chiuso in sé stesso, ma anche molto riflessivo, che ragiona a lungo sulle cose, dalle più semplici e quotidiane alle grandi domande dell’uomo ( si pensi a questo proposito a “Il grande inquisitore” ). È un uomo difficile da comprendere interamente perché ha una personalità complessa, con mille sfaccettature e che rivela un intricato groviglio interiore. Lo si potrebbe quasi definire una persona pragmatica, che a seconda della circostanza in cui si viene a trovare decide di assumere un certo atteggiamento piuttosto che un altro, o di dire determinate cose anziché altre, tanto che a volte sembra parlare per enigmi. Questo suo continuo e instancabile dibattito interiore si rivelerà, però, un peso troppo grosso da portare, una situazione troppo dura da controllare; finché, ormai in preda alla pazzia, si libera di ogni macigno nelle ultime pagine del libro ( il discorso al tribunale ).
È arrivato adesso il momento di parlare del terzo fratello, Aleksèj detto Alëša. Anche qui ci si trova di fronte ad una personalità del tutto differente da quella degli altri fratelli e di conseguenza anche ad un differente rapporto con il padre. Alëša è un giovane molto maturo, con le idee chiare sul suo futuro: continuare nel percorso verso una vita completamente religiosa. È sbagliato, ad ogni modo, pensare che cerchi passivamente nella fede la soluzione a tutte le sue incertezze e la risposta a tutte le sue domande. È un ragazzo che sa ragionare in modo personale sulle cose e che, sebbene sia teso a diventarlo, è cosciente di non essere perfetto. Ha dei lati positivi davvero ammirevoli, quali la disponibilità ad aiutare gli altri, l’apertura al dialogo, la moderazione; ma ha anche i suoi aspetti negativi che talvolta salgono in superficie: la rabbia, l’invidia… ( anche qui appare la convinzione dell’autore sulla presenza nell’uomo sia del bene che del male ). Egli è comunque un personaggio che nel corso del romanzo compie un cammino interiore, attraversa una crescita psicologica: cerca sempre più, passo dopo passo, di giungere ad un miglioramento di sé, in conformità allo stile di vita che ha scelto di seguire liberamente e senza rimpianti. Si può facilmente dedurre, a questo punto, che Alëša è il fratello che con il padre ha i rapporti più distesi, anzi, a dire il vero è l’unico che con lui è riuscito ad instaurare una relazione quantomeno pacifica. Fëdor Pavlovič si fida del suo figlio minore, si apre con lui, prova, a suo modo, un sincero affetto nei suoi riguardi; e Alëša, dal canto suo, cerca di far sentire al padre la sua vicinanza, anche se non è una cosa sempre così facile. Comunque, la sua pazienza viene riconosciuta: Alëša è l’unico che, talvolta, ha la capacità di avere un ascendente positivo sul padre, il quale, consapevole di ciò, nutre un’intima gratitudine verso di lui; pur sapendo, comunque, che non avrebbe mai il coraggio di rinunciare fino in fondo alla propria vita disordinata.
Non è finita qui. Fëdor Pavlovič Karamazov ha anche un figlio illegittimo, chiamato Smerdjakov, che vive in casa come servitore ed è anch’egli un personaggio del tutto enigmatico e singolare. È malato di epilessia e spesso violenti attacchi epilettici lo costringono a letto per giorni interi, a volte settimane. Questa malattia fisica, presentata come molto dolorosa e priva di un rimedio duraturo ed efficace, si accompagna ad uno squilibrio mentale chiaramente identificabile, ma non altrettanto facilmente classificabile. Smerdjakov è un uomo frustrato, il quale, cresciuto con gli altri servi senza ricevere né affetto né attenzioni ( la madre è morta di parto ), vive incapace di provare buoni sentimenti. Cova rabbia, invidia e delusione nei confronti degli altri uomini e si considera una persona sola e sfortunata, condannata a vivere in questo mondo per soffrire. Ha per il padre, che ha fatto di lui un servo, sentimenti di forte rancore e profonda avversione, e la sua freddezza affettiva, la sua non celata insensibilità, lo renderebbe capace di qualsiasi azione, anche la più infame. In un certo senso è possibile vedere nella figura di Smerdjakov la realizzazione pratica del cinismo teorico di Ivàn. È forse il personaggio più ambiguo e imprevedibile del romanzo: è molto difficile riuscire ad intuire i suoi pensieri o a prevedere le sue azioni; il suo disagio fisico e mentale e l’astio da lui accumulato in anni di offese e umiliazioni, lo rendono schivo e taciturno, chiuso nella sua angosciante solitudine. Gli altri personaggi credono di comprendere in maniera sufficientemente chiara le sue problematiche e i suoi conflitti interiori, e in quei pochi momenti in cui si trovano a rapportarsi con lui, lo trattano con distacco e diffidenza.
In questo romanzo, come del resto in molti altri, è evidente il dominio dei punti di vista dei personaggi, e ciò dà origine a quello che Michail Bachtin, un critico russo, grande interprete di Dostoevskij, ha definito “polifonia”: le diverse prospettive dei protagonisti hanno ognuna una propria consistenza e si impongono in maniera del tutto autonoma in confronto alle idee dello stesso autore. Questo determina anche l’originalità dell’uso del tempo: i fatti si svolgono in genere in pochi giorni, ma il tempo viene estremamente dilatato per rispecchiare il modo in cui le vicende vengono percepite da chi le vive in prima persona.
Ritengo che anche da questa famosa opera di Dostoevskij sia possibile ricavare l’impegno dell’autore nel mettere a fuoco le personalità dei personaggi e soprattutto le varie sfumature che queste possono assumere. È inconfondibile lo sguardo attento dello scrittore rivolto a ciò che accade nella mente dei suoi personaggi, che si tratti dei fratelli di cui si è parlato sopra, o che si tratti di una qualsiasi altra figura che eserciti un ruolo di rilievo all’interno dell’opera. E’ sicuramente possibile asserire che la scrittura di Dostoevskij offre una delle più accurate e verosimili descrizioni dei meccanismi di funzionamento della mente umana.
Il giocatore (prima pubblicazione: 1866)

Copertina de “Il giocatore” di Dostoevskij
“…quella sera stessa, mi recai alla roulette. Oh, come batteva il mio cuore! No, non era il denaro che m’importava… Allora volevo soltanto che l’indomani tutti quegli Hinze, quei capi camerieri, quelle magnifiche signore di Baden, che tutta quella gente insomma, parlasse di me, narrasse la mia storia, mi ammirasse, mi lodasse e s’inchinasse davanti alla mia nuova vittoria”.
Bastano queste poche righe, tratte dal capitolo conclusivo del romanzo, per riuscire a comprendere il tema centrale sviluppato da Dostoevskij ne “Il giocatore”, uno dei suoi più famosi capolavori. L’autore scava nell’interiorità di Aleksèj Ivànovič, precettore in casa di un generale, un uomo, quest’ultimo, debole, incapace di imporsi e continuamente preda, nel bene e nel male, dei suoi sentimenti. Il generale, oltre ai due bambini della cui istruzione si occupa Aleksèj, il protagonista e narratore, ha anche una figlia adulta, Polina Aleksàndrovna, della qualeAleksèj è profondamente innamorato. Si tratta, però, di un amore travagliato, di un sentimento, potremmo dire, insano, in quanto Aleksèj davanti a Polina si riduce a uno schiavo, farebbe per lei qualunque cosa. Pertanto, rendendosi conto dell’abiezione in cui lo getta il proprio sentimento, egli comincia allo stesso tempo ad odiarla. Polina, dal canto suo, si dimostra divertita dalla situazione e fiera di sentirsi così venerata da un uomo che pende letteralmente dalle sue labbra. Nei confronti di Aleksèj non lascia mai trasparire alcun sentimento di amore contraccambiato, e nemmeno di affetto o gratitudine, tanto che il giovane matura dentro di sé la profonda e amara convinzione di non poter mai avere un posto nel cuore della sua amata.
Altro personaggio importante all’interno di quest’opera è la nonna di Polina ( anche Aleksèj,, durante la narrazione, la chiama sempre “nonna”, affettuosamente ), la famosa “Madame la Generale” nella cui morte il generale confida, in modo da riuscire, con l’eredità, a far fronte agli ingenti debiti che ha contratto, e a sposare quindi la duchessa de Blanche, donna di cui è follemente innamorato. Ma la nonna è una donna forte e spavalda, che un giorno si presenta trionfalmente a casa del generale, annunciando che in quella cittadina deve intraprendere delle cure mediche. Questo viaggio, però, si rivelerà la rovina della vecchia signora, che perderà tutti i suoi averi al gioco della roulette.
È questo il primo caso di dipendenza dal gioco che il grande Dostoevskij ci propone nel romanzo, ma mentre qui la descrizione si basa principalmente sugli eventi esterni, sui comportamenti assunti dalla nonna, nel secondo caso, quello di Aleksèj, la lente d’ingrandimento è puntata sui meccanismi mentali che provocano il malato attaccamento alla roulette. Lo scrittore porta abilmente e minuziosamente alla luce tutte le implicazioni psicologiche che possono concorrere ad intrappolare un uomo nel vortice della dipendenza. Tutto questo è reso ancora più efficace e convincente dalla scelta letteraria del narratore interno, il quale, parlando della sua storia in prima persona, racconta le cose secondo il suo modo di concepirle, ma facendo allo stesso tempo arrivare il reale messaggio al lettore. Aleksej, come la maggior parte delle persone prigioniere di una qualsiasi dipendenza, nega l’evidenza, stravolge la realtà, è fermamente convinto di avere la situazione sotto controllo, e nemmeno il tentativo del suo amico Mister Astley di aprirgli gli occhi sulla verità riuscirà a dissuaderlo.
“Domani, domani tutto finirà!”: sono queste le parole che chiudono il romanzo e che portano il loro grande contributo nell’aiutare il lettore a delineare la figura de “Il giocatore”. È la ricerca psicologica che ha dimostrato come coloro che sono vittime di una dipendenza sono pienamente sicure di poter smettere in qualsiasi momento, non rendendosi conto di quanto invece necessitino di un forte sostegno. L’interrompere una dipendenza, soprattutto se si trova in una fase avanzata e quindi è consolidata, è infatti un percorso impervio, rischioso, con molti ostacoli e difficoltà; ma soprattutto, il risultato conquistato alla fine ha un equilibrio molto precario: è più facile di quanto non si creda ricadere in tentazione. Per Aleksèj Ivanovič il gioco diventa la ragione di vita, il centro del suo mondo, e questo risulta palese quando, venendo a sapere da mister Astley che Polina ricambia i suoi sentimenti, la cosa lo sfiora appena, quasi non lo riguardasse, e ciò sarebbe stato impossibile da credere nei primi capitoli del romanzo, quando ancora il demone del gioco non gli aveva catturato l’anima.
Volendo descrivere in modo breve ma efficace ciò che si può estrarre dal tema principale di questo romanzo, è utile ricorrere ad un’aforisma dello stesso scrittore, che può concorrere a dare un’immediata comprensione di quello che può essere considerato l’argomento centrale de “Il giocatore”, ovvero la dipendenza:
“A volte l’uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza”. Fëdor Dostoevskij
Bibliografia
- Testo di letteratura: Baldi e Altri, «La letteratura», Torino, Paravia, 2007 (vol. 5);
- “Centouno capolavori russi e altri slavi” (Guide Culturali Bompiani, 1967; a cura di Eridano Bazzarelli);
- F. Dostoevskij, “Memorie dal sottosuolo” (casa editrice BUR, 1990; traduzione di Tommaso Landolfi);
- F. Dostoevskij, “I fratelli Karamazov” (casa editrice SANSONI, 1969; traduzione di Pina Maiani);
- F. Dostoevskij, “Il giocatore” (casa editrice FABBRI, 1968; traduzione di Elsa Mastrocicco);
- Internet (per le immagini)
Fonte dell'immagine in evidenza: sconosciuta, contattare gli amministratori per chiedere l'attribuzione
